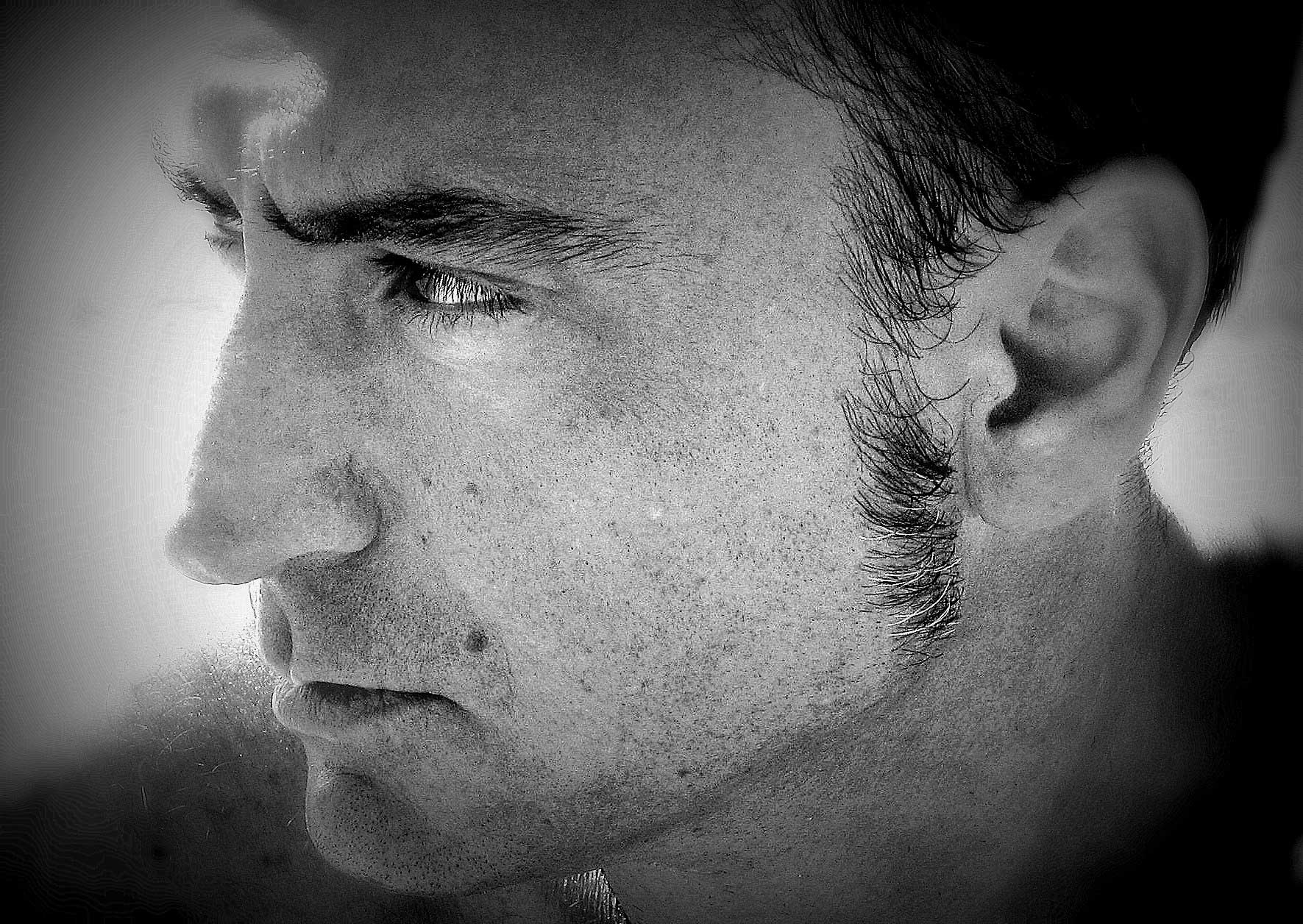INTERVISTA CON VINCENZO FATTORUSSO
Questa chiacchierata con Vincenzo Fattorusso risale a un paio di anni fa: era in corso d'opera il montaggio di Un giorno o l'altro, per l'esattezza. Se la proponiamo soltanto ora, è per motivi indipendenti dalla nostra volontà: stante la grande riservatezza dell'autore, si tratta di una testimonianza che ci sembra oggi ancora più interessante di allora, svincolata com'è da obblighi, impegni, esigenze produttive – e forse in questo sta il suo stesso motivo d'essere. Buona lettura.
Dal suo ultimo lavoro sono trascorsi sette anni…
Non credo che per questo qualcuno consideri irrisolta la propria vita.
I motivi di Un giorno o l’altro.
Il materiale narrativo, anzitutto, e un certo mio desiderio di provare a esprimere coi mezzi del cinema una simile esperienza.
E il teatro?
Il teatro era una soltanto fra le componenti dell’inestricabile groviglio di pretesti, di motivi, di immagini, di seduzioni con cui ti ritrovi esposto all’impresa: non un lavoro su quest’arte né un film storico, pedagogico, quindi, ma il tentativo di fissare un modo espressivo prossimo ai nostri tre uomini, alle loro fatiche; virile e insieme bambinesco, concreto e declamatorio: uno sconfinamento, una prova nel suo farsi, un motivo della memoria, e il bisogno e l’inutilità di tutto questo.
Paolo Bondioli, Guido Ferrarini, Loriano Macchiavelli: come e quando vi siete incontrati?
Ci siamo conosciuti durante la lavorazione di A parte; si era nel 2004, credo.
Come è andata?
La gestazione dell’opera è stata lenta e assai laboriosa: il progetto rischiava di naufragare per imbarazzante gratuità o di rimanere estraneo al nostro lavoro; da questa tensione costante, dal rigore assoluto che la materia, così insidiosa, esigeva è nata la costruzione del film.
Una materia immensa: l’amicizia virile, la militanza politica, lo sradicamento forzato dal proprio ambiente, la giovinezza, la strada, il palcoscenico, la passione civile… E ancora. Il ricordo, i linguaggi, la ricerca di una propria espressione…
Tutto questo, ammesso che nel mio film tali aspetti, per quanto confusamente, ci siano, poteva nascondere ulteriori tranelli: sovrapposizioni, labirintici smarrimenti, caratterizzazioni che avrebbero potuto trasfigurare i tre in personaggi vuoti, tappezzeria di scena, proiezioni da teatro d’ombre.
Anche l’armonizzazione dei materiali, così diversi, avrà dato a lei e ai suoi collaboratori non pochi pensieri…
Ho la fortuna di avere, con me, dei collaboratori preziosi. La mitizzazione dell’autore è qualcosa che mi irrita nel profondo: conosco gli sforzi materiali e l’inquietudine che comporta la volontà di raccontare delle storie, ma tutto questo non ha nulla che vedere con parassiti di cricca impegnati a evitare la fatica vera e ad assecondare quanti fanno quadrato intorno al nulla.
Quelli della loro giovinezza sono stati anni particolari.
Come ho già detto, volevo soltanto raccontare una storia. Certo, vi era in quel tempo un’avversione morale e civile per complicità antiche e comportamenti intollerabili della classe dirigente che offendevano la dignità dell’uomo: ma credo che a restituire in pieno il clima dell’epoca basti il silenzio che oggi segue la parola dignità.
Rivoluzionari? Presuntuosi? Sognatori?
Sono fascette editoriali.
Che cosa rischia di rimanere fuori?
La fierezza e l’orgoglio di appartenere a una razza antica, capace di dare col silenzio le lezioni più alte, che durano per sempre: un conflitto sociale è anche una contrapposizione di linguaggi. La concezione collettivista della società e le seduzioni di un orizzonte urbano fatto di interminabili promesse: qualunque tentativo di affrancamento da una condizione di disagio riceve in cambio soltanto giochi di parole. In questi uomini c’è, a mio avviso, la continuità ideale tra documento e poesia, tra mito e realtà: ma in maniera di destino, senza forzature né furore profetico, da testimoni del passaggio dai suoni così intimi della tradizione orale a tutto questo strusciare di scope.
Come autore, che cos’è, per lei, il cinema?
Mio figlio che sgambetta per casa soffiando in una lingua di Menelìk scovata chissà dove, una raccolta di vocaboli del suo linguaggio redatta in bella grafia dalla madre, le case abitate da mio fratello, la meticolosità illogica e insopprimibile che metti nell’annerire gli spazi di uno scarabocchio.
E come spettatore?
Nel quartiere dove abitavo, lo spettacolo cinematografico era un lusso e nel contempo uno dei grandi riti dell’esistenza; di cinema, in quell’ oscuro angolo di periferia, ce n’era soltanto uno: a pianta circolare, piccolo e col tetto basso, si chiamava Valentino. Insegna al neon, le lettere blu, con la v da simbolo di radice. Circondato da una cancellata bianca, oggi mi pare che ci sia un ambulatorio medico o qualcosa del genere, al suo posto. La prima volta mi ci portò mia madre, per via di certi biglietti omaggio raggranellati chissà come. La sala, percorsa da una gaia marcetta, traboccava di gente: nell’oscurità vedevo braci di sigarette, sentivo voci; a tratti il fascio di luce, riverberato dallo schermo, disegnava i profili di quanti, accosti ai muri, erano in piedi, stretti gli uni agli altri. Nell'aria c'era un odore forte, acido e dolciastro, che prendeva alla gola. Del fatto tecnico in sé ricordo poco: non credo mi colpì, insomma, gran che. Quanto al resto, ero lì nel buio che pensavo ai salmoni martoriati da un enorme orso bruno sul fondo sassoso di un fiume, e venivo distratto di continuo da due bambini che mi sedevano accanto: li conoscevo di vista, erano figli di non ho presente bene chi, e la femmina – a me più vicina, e per solito timida e pudibonda – mi recitava in un orecchio filastrocche sconce come non ne avevo mai sentite. Dovetti sembrarle anche un po’ tonto, credo. Sarà stato per la mia scarsa attenzione, ma non rammento altro: lo spesso tendaggio all’accesso della sala, forse, e la maschera, un uomo senza una mano. Nel rione di là da certi terreni incolti c’era invece l’Impero, uno stanzone col pavimento sconnesso e con le panche di legno, dove la partecipazione allo spettacolo era assoluta, di una straziante vitalità. Cartacce, sguardi obliqui, rauchi scoppi di risa: in quell’atmosfera manicomiale, tra quanti si contorcevano o gridavano gesticolando, c’era qualcosa che mi indisponeva e mi affascinava insieme. Proprio lo stesso sentimento che provo per le giostre, le musichette chiassose e irreali, i burattini, carnevale, l’ultimo dell’anno, le bande, i fuochi d’artificio: tutte manifestazioni, mi pare di capire, che rimandano a una dimensione struggente e favolosa, in sé compiuta, alla quale abbandonarsi senza curarti che il rapporto con le cose viene di colpo a mancare. In quelle sale cinematografiche sarei tornato ancora: soprattutto durante l’adolescenza, ma sempre a fasi alterne. Non ho mai avuto il mito del cinema, dell’artista: è uno dei piaceri che posso concedermi, uno tra tanti.
Non si vede mai come un personaggio artistico?
No, per nulla.
E suo fratello, Ciro?
Qualunque cosa mio fratello sia, posto che valga la pena voler a tutti i costi definire un uomo, lo è nella sua forma più pura. Una limpidezza che si manifesta nel tocco, nelle melodie come nelle dissonanze, nei componimenti che non ritiene di dover dilatare. Nella sobrietà. Più che una mera questione di stile, una necessità, per così dire, genetica, da pesi sulla testa, viottoli polverosi, sguardi tutt'intorno. Non ho sufficiente distacco per analizzare la sua opera, parlarne in termini astratti. Un giorno, durante una pausa di certe prove, attaccò al pianoforte un motivetto che non avevo mai sentito. Sorrideva. “Questo è Angelo”, fece alla fine. Ma lo disse così, come avrebbe detto, che so?: “Questo è un tavolo”. Rimasi pietrificato: sin dalle prime battute avevo pensato allo stesso fraterno, comune amico; un uomo si era fatto musica sotto i miei occhi. Non l'ha mai più suonata, quella specie di cantilena, non la ricordava. Ne capitano tanti, con Ciro, di episodi simili.
Rudi Assuntino lo ha conosciuto personalmente?
Sul finire del 2009 venne a Bologna per un omaggio a Ivan Della Mea; giacché non ci eravamo mai incontrati di persona, cogliemmo a volo l’occasione. In precedenza mi aveva telefonato per complimentarsi circa A parte, e considerai la cosa al pari di un’investitura.
All'epoca fu ospitato al sanleonardo - il teatro creato dal GTV - come tanti altri: Francesco Guccini, Deborah Kooperman, Paolo Pietrangeli, Michele Straniero…
L’entusiasmo fu tale da spingerlo a mostrare l’opera al suo amico Tatti Sanguineti, il quale mi invitò poi nel programma che teneva, con Alberto Crespi, alla radio RAI, per raccontare del film.
Un rapporto particolare, quello tra lei e la radio…
L’ho fatta per anni, mi ha sempre affascinato. Quando avevo sei o sette anni nascondevo con cura, prima di coricarmi, una radiolina bianca e verde sotto il cuscino. Poi spegnevo la luce, andavo a letto. E ascoltavo. La musica che trasmettevano mi lasciava indifferente, e a tentoni ruotavo la rotellina della frequenza o il commutatore di gamma. Altre erano le cose capaci di suscitare un’intensa emozione: come le voci confuse, lontane, appena percettibili in quel loro essere accompagnate da un suono acuto, modulabile, a parlare in lingue a me sconosciute. Annunciatori che, in un’atmosfera da fine del mondo, diffondevano notizie e informazioni. L’assoluta certezza che si rivolgessero proprio a quel bambino rannicchiato sotto le coperte. Il bollettino dei naviganti, scandito da una voce sempre uguale, lenta e nettissima. Dunque a quell'ora c'era della gente che andava per mare. Capivo ben poco di quelle frasi, quasi dei messaggi in codice, ma m’impressionava la solennità del momento, mi piaceva immaginarlo: in quattro o cinque intorno a un grosso ricevitore a fumare in silenzio, assorti; di là dal cono di luce uno scricchiolare di legni.
Un anno fa scompariva Ilario Fioravanti, a cui è legato il fortunato Tracce.
Non c’è giorno in cui non mi imbatta nel ricordo di Ilario Fioravanti. Considero l’incontro con quest’uomo uno degli episodi più fortunati della mia vita. Era un artista capace di confondere, per così dire, il mio senso critico; credo che il solo Testori ne abbia compreso appieno la grandezza. “Vincenzo, Ilario non è più quello di una volta…” ripeteva negli ultimi tempi Adele, l’amatissima moglie: li cercavo a ogni ricorrenza, a ogni occasione propizia, tormentandoli con le mie inopportune domande, i miei vani progetti. Ho saputo della sua dipartita il giorno stesso dei funerali: una nevicata come non si ricordava a memoria d’uomo paralizzava tutto il Nord Italia; era inutile cercare di partire per Cesena, non ci provai neppure. Nelle nostre lunghe chiacchierate Fioravanti tornava spesso sulla parabola dei talenti, questo sermone del Nuovo Testamento, finendo sempre con l’interrogarsi circa il giudizio divino; ora, mentre da dietro i vetri della finestra guardavo quel quadro bianco, la voce della memoria si sovrapponeva ai gridolini di mio figlio: “E il servo fannullone gettatelo fuori nelle tenebre: là sarà pianto e stridore di denti” (Matteo 25, 14-30)
Pochi giorni dopo venne a mancare anche Tonino Guerra.
Io l’ho incontrato poche volte; mi dava soggezione: la parola a un tempo origine e fine, vivi come siamo soltanto in quella emissione di fiato, lo studiato compiacimento col quale si tratteneva dal prendere parte a una conversazione, gli occhi fissi, penetranti. Quando Di partenti e saltimbanchi fu selezionato per un festival in America, Guerra ne fu felice al punto da telefonarmi. Ero chissà dove, e lui, non riuscendo a trovarmi, lasciò nella segreteria un messaggio di rallegramenti, registrazione che conservo come uno dei ricordi più belli di quegli anni. Per sdebitarmi gli inviai alcune delle fotografie che avevo fatto nel giardino di casa sua, a Pennabilli, durante le riprese. Raccontava che, data l’età, nessun chirurgo aveva voluto operarlo al cuore, piuttosto malridotto, e così per l’intervento era dovuto andare in Russia: a mo’ di celia ripeteva che da allora erano tutti giorni in più. Sembrerà strano, ma si è impresso nella mia mente lo sguardo che mi lanciò quando, durante una chiacchierata, accennai a I girasoli: a distanza di tanto tempo continuo a pensare che qualcosa di molto particolare - anche estraneo all’opera stessa, chissà? - lo legasse a quel lavoro, tanto da venire a galla, quasi con stupore, al solo nominare un film che forse non tutti ricordano. Quel lampo mi impedì di andare oltre, e temo che la mia riservatezza mi abbia fatto perdere un’occasione unica. Pure, ricordo certe sue reticenze circa Fellini e Zavattini, tenuti in considerazione di ingegni superiori: quei due nomi avevano il potere di fargli distogliere lo sguardo, di isolarlo in un pudore e in una vaghezza - lui così esatto - tanto improvvisi quanto inquietanti.
Come ci si sente, sulla soglia dei 50 anni – gli ultimi quindici dei quali vissuti a Bologna?
Come sempre: a volte ti sembra di averne venti; altre, settanta. Sei lì, col pensiero a mezz’aria: una di quelle mattine che San Petronio ti pare di poterla buttare giù con un calcio. La luce, che cos’è; mi trovo costretto a oggettivare, per ignoranza non possono venirmi in soccorso spiegazioni da trattato.
Maurizio Sansone